Ritrovare la brasilianità a Milano: intervista ai Selton
Possibile immaginare la vita di un gruppo di brasiliani trasferiti in pianta stabile a Milano? Con un passato da buskers a Barcellona, i Selton sono fra i gruppi più apprezzati del panorama indie rock italiano

Possibile immaginare la vita di un gruppo di giovani brasiliani trasferiti in pianta stabile – o quasi – a Milano? Con un passato da busker a Barcellona, scoperti per caso da Fabio Volo e portati nello storico programma Italo Spagnolo, i Selton sono fra i gruppi più apprezzati del panorama indie rock italiano. Davanti a qualche Spritz, un Bloody Mary e del Prosecco, Daniel Plentz ed Eduardo Stein Dechtiar, percussionista e bassista della band, ci parlano del loro nuovo album, Manifesto Tropicale.
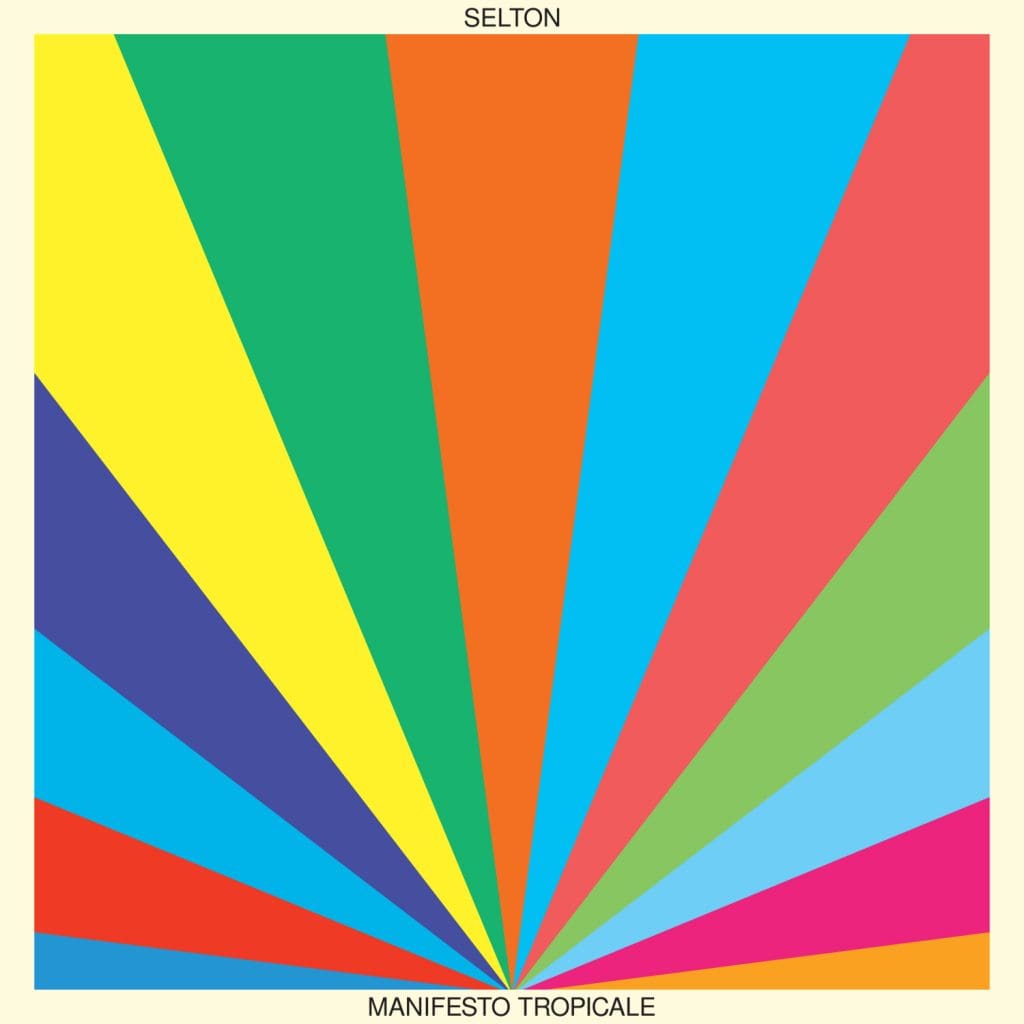
L’intervista ai Selton
Partiamo dal titolo del disco: è ispirato a Manifesto Antropofago, opera degli anni ’30 del poeta brasiliano Oswald de Andrade, giusto?
Daniel. Sì. Il Manifesto Antropofago parte da una riflessione. Alla fine degli anni ‘20 in Brasile si rifletteva sulla vera identità del brasiliano: ci si chiedeva se l’identità brasiliana venisse dall’Europa con i portoghesi o dall’Africa con gli schiavi oppure dagli indios, che erano lì prima. In questo manifesto viene definita la cultura brasiliana come “antropofaga”, che mangia quello che arriva da fuori e lo trasforma in qualcosa di unico. Il disco è nato partendo da una ricerca personale dell’identità e della nostra natura ibrida data dal vivere in Italia ma cantare in italiano, portoghese, inglese e anche spagnolo in questo disco! Ci siamo chiesti: chi siamo noi? Da dove arriva la nostra brasilianità?
Mi pare che il tema della ricerca dell’identità sia stato anticipato dalla canzone Qualcuno Mi Ascolta? contenuta in Loreto Paradiso quando dite: E poi mi chiedi se mi manca il mio paese / Se lì si parla basiliano o portoghese […] Se torno a casa, se mi sento un milanese.
D. Sì, Qualcuno Mi Ascolta riflette sul fatto di essere straniero in Italia, sui luoghi comuni. Italia: pizza e focaccia. Brasile: samba e calcio. Tutti questi atteggiamenti sull’identità sono tornati nella produzione di questo disco, perché vediamo una Milano e un’Europa sempre più contaminate dalle culture. Vedi Ghali che fa un ritornello in arabo, vedi Liberato che canta in napoletano strettissimo: tutte queste cose ci hanno fatto riflettere. Siamo partiti dall’inizio del secolo scorso per parlare di quello che vediamo intorno a noi oggi.
Nei testi delle canzoni dei Selton ci sono molti riferimenti alla famiglia. Ricordo in una vecchia canzone la menzione dei fagioli cucinati dalla mamma in Brasile. Anche in questo disco ho sentito diversi riferimenti all’idea di famiglia.
D. Siamo molto legati alla famiglia, sì. Ci sono persone che emigrano e iniziano una nuova vita, quasi come se la vita passata non fosse esistita. Noi abbiamo un legame fortissimo. Sentiamo casa un paio di volte a settimana.
Eduardo. C’è da dire che siamo partiti dal Brasile per fare un viaggio che doveva durare un anno. Quindi era un “vado ma poi torno”. Poi sono successe così tante cose… Al tempo stesso c’è stato un grande supporto dalle nostre famiglie. Non è facile essere lontano da casa: dopo 10 anni anche Milano è casa, però…
Restando in tema viaggio, siete sempre in costante movimento, dal Brasile a Barcellona a Milano. Se la vita e la carriera dei Selton fossero un viaggio, quale sarebbe la prossima meta?
D. C’è un viaggio che vogliamo fare ancora. Faccio spoiler: è prendere un pullman dalla Terra del Fuoco e arrivare fino in Canada, tutto registrando un disco.
E. Con Tommaso Colliva che guida e registra. E cucina!
A proposito di Tommaso Colliva, la produzione del disco è stata fatta proprio assieme a lui. Quanto ha influenzato il risultato finale o rimaneggiato i pezzi che avevate in mente?
D. Molto! È il quarto disco che facciamo assieme a lui, che è diventato in effetti un quinto Selton. Ci ha influenzato molto ed è stata la prima volta che abbiamo avuto la possibilità di uscire da Milano. Siamo andati a Londra, dove vive Tommaso, e abbiamo preso per quindici giorni uno studio. Alcune canzoni sono nate o sono state finite proprio lì: a volte davvero avevamo pezzi abbozzati, al massimo un riff di chitarra, che però è diventato una canzone. Il processo con Tommaso è stato decisivo.
Rispetto ai precedenti lavori Manifesto Tropicale suona più triste. Vi ho trovato più riflessivi, più malinconici.
D. È vero, ma c’è una premessa. C’è una cosa che afferma David Byrne che ci ha fatto riflettere molto. Inizialmente lui pensava che se non fai musica triste o urlata non hai spessore artistico. Poi si è ricreduto quando ha scoperto la musica brasiliana: puoi avere spessore anche se sei allegro. È stata una nostra battaglia. Negli ultimi dischi abbiamo sempre fatto una musica considerata leggera, ma nel senso negativo della parola. La nostra reazione era sempre: “Ma avete ascoltato i testi? Avete capito l’ironia che c’è dietro?”. Però non abbiamo fatto apposta un disco più triste! Il risultato delle nostre vite è stato questo album. Abbiamo notato che la gente ci ha capito molto meglio. Ed è stata una cosa tipo: “Ah! David Byrne aveva ragione!”.
Per il lancio del disco avete fatto un mini showcase nel cortile della vostra casa a Loreto: come mai casa vostra e non un locale o una libreria?
D. Il primo concerto a casa è stato per il disco precedente, che si intitolava Loreto Paradiso ed era partito dall’idea di trasformare quel posto in una spiaggia tropicale, con la sabbia e le palme. Per questo disco non siamo riusciti a replicare la stessa cosa ma abbiamo detto: “Facciamo lo stesso un concerto a casa”. Tanto in quel palazzo abitiamo tutti e quattro, tutte le mattine ci salutiamo dal balcone, mangiamo assieme, facciamo le prove. Ho detto: “Ragazzi, questa roba sembra un po’ la versione povera di Friends!”.
Ultima curiosità: per la promozione del disco girava sui social una foto con un vostro cartellone pubblicitario sul palazzone in Piazzale Loreto, giusto dietro casa vostra. Era vero oppure no?
D. In tantissimi ci hanno creduto… ma perché rovinare una bella storia con la verità?








