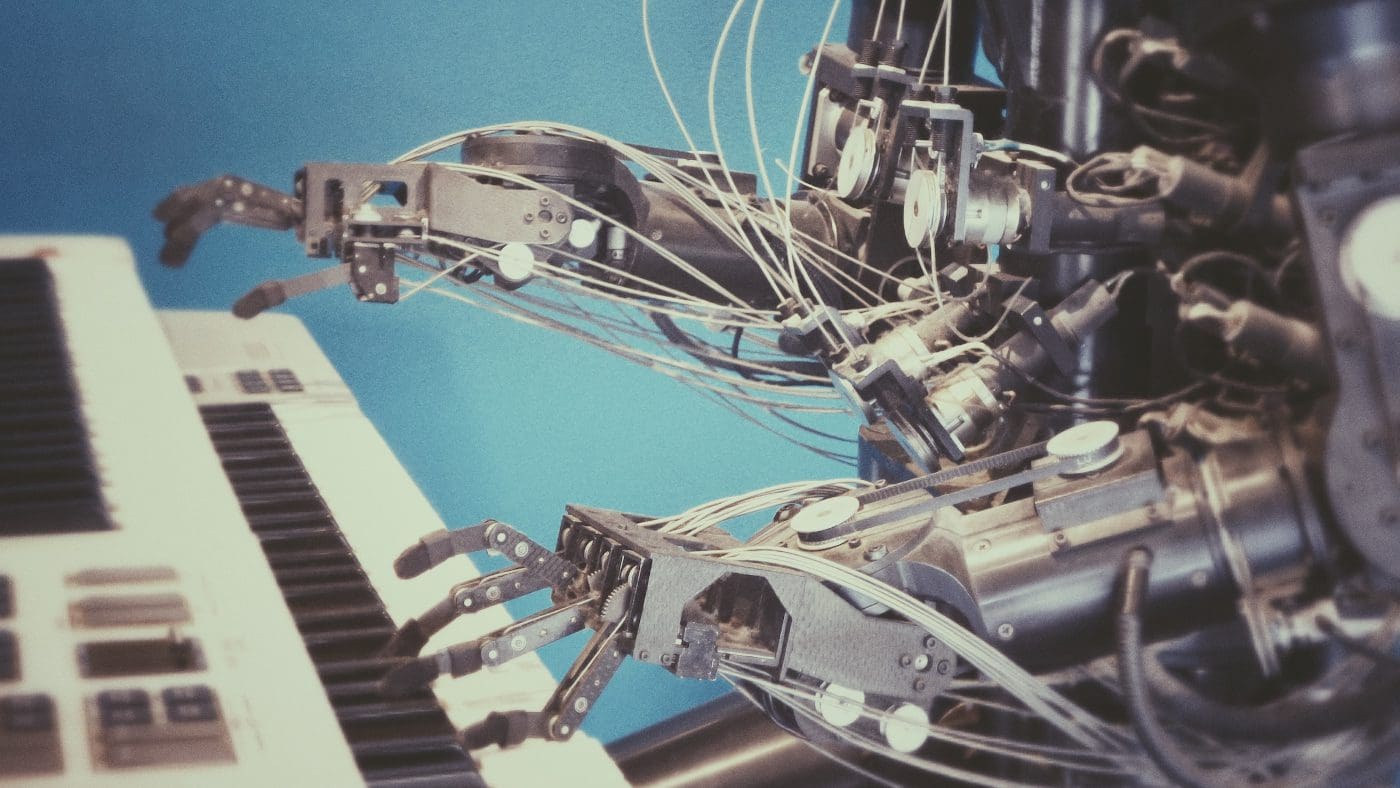Cos’è il “value gap”?
Le piattaforme di condivisione video, con quasi un miliardo di utenti, generano meno introiti per l’industria discografica rispetto ai servizi di streaming, che contano un quarto degli utenti: perché?

Il confronto non regge: chi ascolta musica sui siti di condivisione video genera ricavi per l’industria discografica quasi venti volte inferiori a quelli prodotti da chi sceglie piattaforme di streaming. I numeri non mentono: i 900 milioni di utenti che nel 2016 hanno ascoltato su YouTube & co. i propri artisti preferiti hanno macinato ricavi per 553 milioni di dollari ridistribuiti a produttori e interpreti in tutto il mondo; invece i 212 milioni di fan con accesso ai servizi di streaming audio hanno permesso al sistema-musica di drenare globalmente 3,9 miliardi di dollari. Una differenza non da poco che si fonda sul diverso riconoscimento giuridico di cui godono i siti di condivisione video rispetto a piattaforme come Spotify, Deezer e Apple Music: «YouTube paga poco perché un baco normativo permette a Google di non avere alcuna responsabilità sui contenuti pubblicati sul portale. Il sito viene considerato un semplice intermediario di prodotti caricati dagli utenti e se la cava con la promessa di cancellare i brani protetti da copyright», spiega Enzo Mazza, Ceo di FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) e soldato numero uno nella battaglia contro il value gap, ossia la differenza tra il valore economico di ogni singolo brano e l’incasso riconosciuto ai produttori.
Per Spotify e i suoi fratelli il discorso è diverso: acquistano il diritto a trasmettere musica e dialogano con le case discografiche seguendo logiche di mercato. I risultati si vedono: nonostante un numero decisamente inferiore di utenti, le royalties generate sono maggiori e sfiorano i 4 miliardi di dollari a livello mondiale. I siti che mettono in vetrina i contenuti prodotti dagli iscritti, al contrario, giurano di rimuovere in fretta tutto ciò che lì proprio non può stare; ma la reattività dei controllori non è pari alla velocità degli smanettoni che con pochi click mettono a disposizione gratis l’ultima hit: «L’industria musicale ha dovuto accettare di monetizzare i suoi brani con l’advertising – dice Mazza – ma quando si è dovuto negoziare le percentuali le piattaforme di video erano in posizione di forza e l’accordo è stato al ribasso».
Negli Stati Uniti la battaglia contro i giganti della Silicon Valley è data per persa. In Europa si lotta per rendere più omogeneo il mercato dello streaming musicale. La faccenda è comunitaria e da tempo rimbalza tra Parlamento, Commissione e Consiglio il testo che promette di sciogliere l’enigma: «Vogliamo che l’Unione Europea chiarisca qual è il ruolo delle piattaforme che gestiscono il caricamento dei contenuti da parte degli utenti – continua Mazza – e puntiamo a far riconoscere la loro responsabilità quando non riescono a rimuovere i brani: solo così i giganti della rete potrebbero essere propensi ad acquistare le licenze musicali sul mercato».
L’Unione Europea considera il value gap una dinamica distorsiva per la concorrenza ed è per questo che si guarda con fiducia a una possibile soluzione politica: «La posizione degli Stati ormai è meno tollerante nei confronti dei grandi operatori della rete – prosegue Mazza – Lo si vede anche nel dibattito sulla web tax: quelli che erano i “good boys” di una volta ora non lo sono più così tanto». A differenza di quanto accadeva nei primi anni Duemila, si cerca di limare il potere degli over the top arginando la loro libertà di manovra: “L’Europa – ricorda Mazza – è un continente storicamente legato alla produzione dei contenuti e ha l’interesse di difendere artisti e produttori. Italia e Francia guidano il gruppo di Stati che all’interno del Consiglio Europeo sono prevalentemente favorevoli alla tutela dei contenuti e degli autori, la sola strada che garantisce gli interessi della produzione culturale».
Se – per assurdo – ai grandi portali del video streaming dovesse essere bandita la pubblicazione dei brani online, non è detto che per l’industria discografica sarebbe un dramma. Una recente indagine finanziata da Google spiega che se YouTube fermasse all’improvviso la trasmissione di canzoni l’85% dei suoi utenti mondiali si disperderebbe tra servizi pirata o a basso valore aggiunto. In Italia solo il 13% di chi frequenta il portale sceglierebbe soluzioni high value, scatenando paradossalmente un effetto positivo sui conti dell’industria discografica: quella piccola porzione di utenti in versione premium varrebbe oltre 25 milioni di euro, molto di più di quanto versato da tutte le piattaforme video alimentate con la pubblicità (10 milioni nel 2016).
Nel primo semestre del 2017 i ricavi dallo streaming tout court – video e audio – sono stati 26,8 milioni di euro, il 44% del fatturato complessivo dell’industria discografica. Tuttavia all’interno del micro-segmento la distribuzione della ricchezza non è stata uguale: dagli spot presenti nei video sono arrivati in sei mesi 5,3 milioni di euro, l’advertising audio (ad esempio Spotify in versione gratuita) ha portato nelle casse 4,6 milioni e gli abbonamenti premium hanno fatto il resto con 16,8 milioni di euro di ricavi – il 50% di tutto il valore del digitale italiano (compresi i dischi venduti su iTunes). «La musica – sentenzia Mazza – riceve molto meno di quanto le spetta» e il value gap si mostra in tutta la sua potenza quando si confrontano le revenue prodotte dai soli siti di video streaming con quelli di una tenace nicchia di settore: «Il piccolo mercato del vinile genera oggi esattamente gli stessi ricavi prodotti da YouTube, poco più di 5 milioni di euro nei primi sei mesi dell’anno».
di Michele Chicco