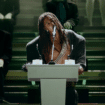The Bug: «Ho smesso con le droghe anni fa. Con la musica ho cambiato fonte di serotonina»
Il suo è un dub oscuro, minaccioso, esplicito. Abbiamo ancora disperatamente bisogno di musica sovversiva come quella di Kevin Martin

The Bug (foto di Caroline Lessire)
Kevin Martin fa parte di quella ormai quasi estinta cerchia di artisti che trasformano in oro ogni cosa che fanno. Ovviamente non lo stesso oro che dalla notte dei tempi ha portato solo morte e devastazione al genere umano. Bensì quello che banalmente cerca chi ha il pallino per la musica senza compromessi: dischi bellissimi, pieni di mistero, mai del tutto afferrabili, irrisolti, intrisi di struggle, sempre e comunque anticipatori dei tempi. Tesi sempre in avanti.
Manco a voler confermare tutta la faccenda dell’oro, uno dei suoi progetti più belli si chiama proprio King Midas Sound. Ma tra i suoi più famosi sicuramente va menzionato Techno Animal, insieme a quell’altro genio di Justin K. Broadrick (con cui ha diviso anche GOD e Ice), e ovviamente il suo più importante, quello solista: The Bug.
“Whenever I’m feeling a bit cocky i put this on and put myself back in my place”, recita il commento più likeato sotto il video YouTube di Skeng, uno degli inni più conosciuti di The Bug, oltretutto con un leggendario Flowdan al microfono.
Trovo sia un modo molto efficace di riassumere la natura del suo dub oscuro, minaccioso, esplicito. È un’indole incazzosa (solo nella musica, perché nella vita è una persona dolce e simpatica) che The Bug stesso identifica in un passato familiare traumatico. Una brutta ferita interiore che però è riuscito a suturare diventando un padre amorevole.
Ma, come sappiamo, i mali di questo mondo impazzito non si risolvono trovando l’amore. Allora ecco che i bassi osceni e tutta la sfilza di MCs di cui si circonda The Bug tornano sempre utili, se non addirittura necessari. Abbiamo ancora disperatamente bisogno di musica sovversiva e refrattaria come quella di The Bug.
Chiamo Kevin un giorno in cui a Milano piove e a Bruxelles, dove vive con la moglie e i suoi due “little bugs”, c’è un bel sole. Si gode una città che lo ha accolto tre anni fa in un momento difficile e che ora, dopo decenni a Londra e Berlino, è diventata la sua casa.
Il 30 giugno The Bug si concederà una notte in Italia, in compagnia dello stesso Flowdan, per inondare di tsunami sonori il Lost Festival, nel Labirinto della Masone a Parma.
L’intervista a The Bug
Posso essere indiscreto da subito? Come si riesce a essere un artista che fa dischi, li porta in tour e nel frattempo è anche un padre?
È una bella sfida, non posso mentire. In tutta sincerità, per buona parte della mia vita ho creduto che non sarei mai stato un genitore. Sono cresciuto in un ambiente familiare davvero ostile, con un padre che menava moglie e figli. Ma quando ho incontrato la giusta persona nel giusto momento, era indiscutibile.
Una volta che ho preso quella decisione, ero determinato a non essere un padre fantasma, totalmente assente come mio padre o come molti altri padri nella musica. Per fortuna ho una partner davvero comprensiva, che sa essere molto paziente riguardo alla mia professione. Cerchiamo di bilanciare. Impariamo ogni giorno, tanto quanto i nostri figli.
Beh, ti ammiro. Io ho un cane da solo e sto impazzendo.
È stata dura, in particolare negli ultimi due anni, sai, col Covid. Credevo di impazzire. Ci siamo trasferiti a Bruxelles letteralmente il giorno prima che ogni confine venisse chiuso. Siamo stati costretti: dovevamo trasferirci sei settimane dopo, ma quattro giorni prima mi sono reso conto della gravità della situazione.
Ho detto a mia moglie: “Ok, la situazione è seria. Se non ci muoviamo ora rischiamo di trovarci nella merda. Se i confini chiudono siamo fottuti, perché abbiamo già dato disdetta della casa e dello studio. In più perderemo la cauzione che abbiamo già dato per l’appartamento a Bruxelles”. Quindi nella peggiore delle situazioni ci saremmo trovati senza fissa dimora.
A Londra?
No, all’epoca vivevamo a Berlino. Ci abbiamo vissuto otto anni. Quindi niente: siamo andati a Bruxelles la domenica. Il lunedì, tutti i confini erano stati chiusi tra Germania, Belgio e la maggior parte degli stati europei. Da lì è stato folle. E non è consolante il fatto che è stato folle per chiunque. Volevamo tutti delle risposte ma nessuno ce le aveva.
Una volta presa la decisione, avevamo quattro notti per impacchettare tutto, compreso il mio studio che è una cazzo di astronave. Il problema però è che nessuna azienda di traslochi tedesca voleva accettare il lavoro, per paura di non riuscire a tornare indietro in Germania se avessero chiuso i confini.
E allora come avete fatto?
Ho dovuto appoggiarmi a una società turca che non sembrava affidabile. Mi sono cagato sotto. Quando siamo arrivati a Bruxelles, abbiamo realizzato che lì prendevano la faccenda della pandemia molto più seriamente di Berlino.
Sembrava una distopia fantascientifica: una persona alla volta nel negozio, e cose così. È stata una città fantasma per mesi. Ho visto lentamente le mie date venire cancellata una dopo l’altra. Per mantenermi sano di mente ho allestito al più presto il mio studio.
È stato pesante, più che pesante. Lo è stato per tutti. Però una soluzione economica molto utile è stata Bandcamp. Cazzo, è stata una risposta lunga alla tua domanda. Per riassumere, adoro essere padre dei due little bugs. Dito medio alzato per il mio passato traumatico.
Amen. E ai “little bugs” piace la tua musica?
A mia figlia probabilmente non moltissimo. Le piace il fatto che faccio musica e ne sono appassionato. Diciamo che troviamo un terreno comune in Rosalía, che piace anche a mia moglie. Però la porto a qualche mio show, quando magari c’è anche zio Flowdan.
A mio figlio invece piace la mia musica. Gli piace l’hip hop, il reggae. Ascolta un botto di grime. Sicuramente è una bella cosa però per i bambini, perché non è proprio comune avere un padre che fa il mio mestiere.
Ti sei mai chiesto come mai la tua musica è così minacciosa?
In realtà non ho mai avuto scelta. Quando ho iniziato a fare musica, era come una terapia. Era un urlo primordiale. Oggi c’è così tanta gente che fa musica in ottica di una carriera.
Io avevo lasciato la scuola: non avevo nessuna qualifica, nessun posto dove stare, perché mio padre mi ha sbattuto fuori casa a 16 anni, e ovviamente nessun quattrino in tasca, perché di certo non sono nato ricco. Tutto ciò che avevo era una passione per la musica.
All’epoca c’era in giro tanta musica punk che aveva le risposte alle mie domande su quanto fosse una merda la vita, specialmente nel rapporto coi miei genitori, sul rapporto con le istituzioni governative, sull’istruzione. Il punk prendeva tutte le fonti del caos del mondo, le rifletteva, le torturava. È stato illuminante.
Eri molto giovane?
Giovanissimo, appena adolescente. Ma è stato il post-punk a farmi venire la voglia di fare musica, di avere una band. La mia dieta era composta da Throbbing Gristle, Birthday Party, Joy Division, 23 Skidoo, Killing Joke, Public Image Limited. Tutta quella roba mi faceva sentire come se potessi e volessi farla anche io.
Una volta che ho iniziato, è diventata una dipendenza. E lo è tuttora. La musica è la mia droga. Ho smesso con le droghe e l’alcol anni fa. È il suono che fa quel lavoro ora, ho semplicemente cambiato la fonte della serotonina. Fare soldi con la musica non è mai stato nella mia testa. La musica è un bisogno primario per me.
A proposito di endorfine: io c’ero all’Unsound di Cracovia due anni fa, nel tuo primissimo show dopo la pandemia. È stato devastante. Bellissimo.
Ah, c’eri! Sai però qual è stato il problema di quel live? Di solito quando lascio istruzioni sull’illuminazione agli addetti alle luci, capiscono al volo e tutto fila liscio. Ma quando ho chiesto molto fumo all’inizio, mica mi aspettavo che avrebbero invaso completamente la sala di un fumo impenetrabile per tutto lo show. Non ho visto un cazzo per tutto il live, neanche la prima fila di gente. Né tantomeno io vedevo la gente, ed è stato strano.
In più i miei monitor di solito sono a un volume osceno, quindi non vedevo e non sentivo il pubblico. Ero un bozzolo sonico che mi impediva di godermi finalmente il pubblico dopo così tanto tempo. Mi sono reso conto di quanta gente c’era solo dopo la fine. Mi sono detto: “Cazzo, questo posto è pieno zeppo di gente!”.
Sì, non ti abbiamo visto per tutto lo show!
Lo so, però ti dirò anche che non è importante. Onestamente, il palco non è il mio habitat naturale. Magari quando ho iniziato con la musica, quando tenevo un microfono in mano. Forse all’epoca le parole sgorgavano da me, perché avevo bisogno di attenzione. Ma è stato proprio negli anni della band che ho realizzato di non essere proprio a mio agio sul palco, al centro dell’attenzione.
Paradossalmente, con The Bug, avere un sound immenso e sparire dietro a mura di speaker mi fa stare bene. Ben venga essere invisibile: voglio che la gente escluda l’intelletto per essere investita da uno tsunami oceanico di suono. Voglio che la gente si perda nelle onde sonore.
Beh, è anche un po’ la missione del Lost Festival: sei mai stato nel labirinto a Parma?
No, ma mi sono informato e sembra una roba fighissima. Adoro suonare in Italia appena posso. Adoro anche l’imprevedibilità italiana: in Italia ho avuto anche tra le più brutte esperienze live. È sempre un bel caos suonare da voi.
Catania è una delle città più belle dove sia stato in vita mia, eppure ci ho fatto una delle date peggiori (ride, ndr). Perché non c’era neanche un’anima tra il pubblico: solo i baristi di questo piccolissimo evento. Proprio loro però sono stati tanto gentili da portarci del cibo per consolarci.
Ricordo ancora nitidamente i pomodori che ho mangiato quel giorno. Sembravano usciti dall’Eden, così belli, dolci e saporiti: praticamente eroina. In Inghilterra invece abbiamo delle cose rosse che non sanno di niente. Immaginati per un vegetariano poter mangiare per la prima volta quei frutti siciliani.
Ti manca mai Londra?
Decisamente no. Ho vissuto lì trent’anni ed è sempre stata una relazione di amore/odio. Non ho mai avuto soldi, quindi ho costantemente cambiato di quartiere ogni volta che gli affitti si alzavano. Se sei ricco, Londra è una città straordinaria. Se non lo sei, ti punisce, ti tortura.
Uno degli ultimi quartieri dove ci siamo trasferiti si chiama Poplar, in assoluto uno dei più poveri. Tra l’altro, è dove Flowdan è cresciuto. Lì non c’è nessuna integrazione: ogni sottocultura o etnica gira con la propria gang e non si mischia con le altre.
All’epoca io e mia moglie eravamo ancora fidanzati. Ricordo che dovevamo incontrarci alla fermata del bus, a 200 metri da casa mia, perché non era per niente sicuro andare a casa da soli. Siamo stati inseguiti più di una volta.
Lì di fianco hai Canary Wharf, con tutte le banche e la ricchezza più sfrenata: è un contrasto allucinante. Stiamo tornando al Medioevo. Castelli lussuosi e tutto attorno catapecchie.
Ora a Bruxelles è tutto diverso.
Ironicamente, anche ora viviamo nella zona più povera e multiculturale di Bruxelles, Saint-Joos. Però non potrebbe essere più diversa da Poplar: apri la porta di casa e non sai quale lingua sentirai parlare. È un melting pot di culture che convivono pacificamente. Voglio dire, devi proprio essere uno stronzo per essere razzista, dai.
È un posto fantastico: ci sono congolesi, russi, turchi, curdi, polacchi, marocchini, algerini. Sono io la minoranza, e lo adoro. Però è bello anche tornare a Londra ogni tanto, sapendo di non doverci vivere. Sono molto riconoscente con quella città: mi ha plasmato musicalmente. Pensa solo alla jungle, alla dubstep…
Beh, non ci sarebbe stato London Zoo.
Infatti. Tra l’altro la label non amava quel titolo. Ma alla fine si sono resi conto anche loro che il titolo era perfetto. Litigavamo spesso, non era niente di personale. Non ho mai visto l’industria come un’amica. Ma è anche questo un elemento caratterizzante di The Bug. Se avessi voluto fare pop, la mia musica sarebbe molto diversa ora.
Avere a che fare con le etichette non è facile, perché penso semplicemente che la musica e i soldi non c’entrano un cazzo. Non ho niente contro Ninja Tune. Mi fa ridere che in un’intervista i fondatori hanno detto che sono uno degli artisti più eccentrici con cui abbiano mai lavorato. Ed è folle perché hanno lavorato con gente come Roots Manuva o Wiley, che sono molto eccentrici, stilosi.
Quindi la musica con un certo messaggio politico non ci azzecca nulla con una label?
No, e ora più che mai c’è bisogno di musica impegnata. Tutte le cose di cui abbiamo parlato, più il cambiamento climatico, sono temi da affrontare qui e ora. Con ogni mezzo possibile. Il mondo in cui viviamo è ancora più impazzito di quello in cui vivevo da ragazzino ai tempi del punk.
La musica per me è un percorso attraverso il caos. L’ispirazione è costantemente là fuori, cercare di decifrare la follia. Tutto è un atto politico: sia che tu faccia musica come la mia, sia che tu la faccia solo per i soldi.
Peccato che la seconda sia la scelta sbagliata.
Sì. Però, senti: se qualcuno mi offrisse un botto di soldi per fare quello che faccio, li prenderei. Ma non scenderei mai a compromessi. Non sono un tipo nostalgico, non passo troppo tempo a pensare ai bei tempi del punk. Sono sempre in cerca del prossimo beat, del prossimo punk, della prossima mentalità hardcore da parte di musicisti e artisti.
È sempre lì, solo che si evolve ciclicamente. Magari non ha la stessa forma del punk dei Discharge o i Crass. Ma è una cosa che esisteva molto prima del punk. Il reggae era punk, il jazz in America era punk. Oggi l’hip hop è una delle forme più punk di oggi, perché è accessibile a tutti, anche i più poveri, e veicola molto bene i messaggi.
La musica deve avere un messaggio politico, per quanto non sia mai stato un fan delle polemiche plateali. Ho sempre trovato più interessante la decodifica del messaggio politico nella musica, come facevano i Clash.
È un approccio più elegante.
È più profondo, meno superficiale. Riflette la complessità della vita, che non è tutta bianco e nero. Come chiunque dotato di un cervello sa molto bene che la vita è una cazzo di psichedelia. Per me la musica è un canale meditativo per decifrarla.