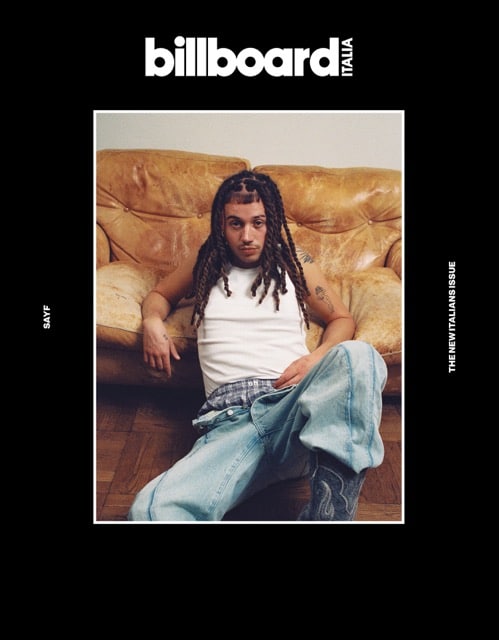Per uno sguardo variegato, inclusivo e meno eurocentrico: intervista a Caterina Barbieri
La compositrice, multistrumentista, producer e neo-direttrice della Biennale Musica di Venezia ci regala una prospettiva inedita sul ruolo della musica elettronica

Foto di Andrea Avezzù. Courtesy La Biennale di Venezia
Arriviamo qualche minuto in ritardo per l’intervista con Caterina Barbieri ma è lei a scusarsi, dicendo che doveva portare il suo strumento dal dottore. È il suo amato e iconico sintetizzatore analogico modulare che ha portato a riparare. «Sono rimasta tre ore dentro al negozio perché ho trovato un po’ di ragazzi nerd come me e abbiamo parlato solo di creatività, tecnologia, sintesi: mi sono ricordata del perché ho deciso di venire a vivere a Berlino!».
Caterina, compositrice, multistrumentista, producer, nata a Bologna nel 1990, diplomata al Conservatorio e poi in musica elettronica, si è trasferita qui quasi dieci anni fa. A novembre è stata nominata direttrice della Biennale Musica di Venezia – che quest’anno si intitolerà La Stella Dentro / The Star Within e si svolgerà dall’11 al 25 ottobre (qui i biglietti) -, quindi nell’ultimo periodo ha passato parecchio tempo in Laguna. Ma tornare a Berlino, in mezzo a quella che lei considera la “sua” gente ha per lei un enorme valore aggiunto.
L’intervista a Caterina Barbieri
Una svolta decisamente importante nel tuo percorso è stata proprio la scoperta del tuo strumento in Erasmus a Stoccolma.
Esatto, pur studiando musica elettronica non conoscevo nello specifico questi strumenti perché sono piuttosto rari, mentre a Stoccolma hanno la collezione di primi sintetizzatori modulari Buchla. È stata una rivelazione per me ma quando mi sono trasferita a Berlino non potevo assolutamente permettermene uno, così me lo sono fatta costruire apposta! Certo, non è originale Buchla, ma ti dà un’enorme libertà creativa. E poi c’è anche il senso un po’ anarchico del non voler comprare uno strumento industriale già pronto ma del costruirsi la propria personale filosofia del suono. Grazie a questo strumento, in versione molto ridotta, è nato il mio primo lavoro Patterns of Consciousness nel 2017.
Perché hai deciso di andare a Berlino e non a Stoccolma?
Volevo assolutamente trasformare questa passione in un lavoro e mi sembrava di poterlo fare solo a Berlino. La scintilla che mi ha fatto davvero venire voglia di trasferirmi in Germania è stato l’Atonal Festival, dove poi sono andata ad esibirmi tante volte. Ma la prima che ci sono stata sono rimasta folgorata, soprattutto dal luogo: questa ex centrale elettrica così suggestiva, il Kraftwerk, pura archeologia industriale che pare una chiesa sconsacrata. Lì ho visto soprattutto per la prima volta la comunità della musica elettronica berlinese e ho capito che avevo bisogno di espandere i miei orizzonti. È ancora quello il motivo per cui sono qui. Sono anche tornata per quattro anni in Italia, a Milano. Però a Berlino la musica è davvero una questione rilevante, Milano è più la città di design e moda.
Cosa succede a Berlino che è difficile vedere in altre città?
Qualche giorno fa, per esempio, abbiamo organizzato un evento legato alla mia etichetta discografica, Light Years, in un luogo pazzesco con un impianto audio quadrifonico incredibile, gestito da un ragazzo che non vuole utilizzare i social. L’ascolto è avvenuto in tranquillità e con profondità, ed è stato sicuramente uno di quei momenti in cui ho pensato: che bello vivere qui. Tra l’altro di un disco, Cantos Yoruba de Cuba appena uscito, del mio primo professore di chitarra classica, Walter Zanetti. Mi piace dare spazio alla musica italiana quando posso.
Vuoi dare spazio anche alle donne italiane?
Mi piace molto l’idea e cerco di farlo, anche nelle scelte che devo fare per la Biennale Musica, ma non è semplice.
Hai vissuto delle discriminazioni sulla tua pelle per essere una donna, anche se sei cresciuta in un ambiente decisamente colto?
Altroché, a partire dagli studi al Conservatorio, e questo fa capire quanto sia radicata la misoginia anche nel mondo della formazione. Per esempio, studiavo composizione elettro-acustica e non si parlava mai e poi mai di compositrici donne, invece ci sono state molte pioniere importanti, però se non ne parli cresci senza modelli. E in te cresce il tema dell’insicurezza perché inizi a pensare che non possa esistere la possibilità di far carriera in quel campo. Come in ambito pop-rock le donne sono relegate a essere al massimo cantanti o nella musica classica musiciste. Ma raramente hanno posizioni autoriali e creative. Per questo sono scappata via dall’Italia durante i miei studi.
All’estero hai visto una situazione migliore?
Un po’ sì. Sempre durante il mio Erasmus a Stoccolma, quindi più di dieci anni fa, si parlava già di supportare la sensibilità femminile e per me è stato estremamente liberatorio il fatto che un professore mi avesse chiesto che cosa volessi fare davvero per far sentire la mia voce. Per la prima volta ero davvero protagonista.
Il mondo dell’elettronica è leggermente più avanti rispetto a quello del pop?
Di poco. Perché si parla di strumenti e macchine che sono da sempre appannaggio maschile. Quindi il fatto che una donna se ne interessi crea un duplice effetto: da una parte gli uomini sono incuriositi ma dall’altra si sentono diffidenti e minacciati, e tutto ciò si trasforma in vero e proprio astio. Poi per me le cose ora sono cambiate: sia per la mia posizione diversa sia per i tempi che sono un po’ migliorati.
Tu hai detto di passare molto tempo in Laguna: è importante per la costruzione di questa Biennale?
Non capisco come mai non lo avessero fatto tutti i direttori in precedenza (so che ci rimase molto tempo la direttrice precedente), perché per me è fondamentale. Anche per il rapporto che si instaura con le persone che ci lavorano e con quelle che ci vivono.
Inviterai molti artisti del posto?
No, non è detto. Però, per esempio, la cerimonia d’apertura dell’11 ottobre si riallaccerà a una consuetudine cittadina, che è quella dei barchini usati come se fossero scooter nelle grandi città, dove vengono posizionate anche le casse. Verrà messa in scena una sorta di processione con un progetto artistico in mano a Chuquimamani-Condori di origini boliviane. Mi piace molto l’idea di unire origini così diverse.
Quale sguardo vorresti che rimanesse di questa Biennale?
Vorrei che fosse legato alla contemporaneità ma non per forza accademica, come è accaduto in altre occasioni. Vorrei fosse ricco, variegato, inclusivo e anche meno eurocentrico possibile. Il mio obiettivo è creare delle connessioni con realtà che possono sembrare lontane, sia temporalmente che territorialmente. Ad esempio ci saranno molti rimandi alla musica antica, come quella medievale.
Invece che rapporto senti di avere con la musica elettronica techno?
Sono appassionata, soprattutto a quella delle origini e ho sempre riscontrato molti punti in comune alla mia ricerca, anche se io non uso l’elemento della percussione. Mi affascina il rapporto creativo con la dimensione delle macchine. Magari frequento un po’ meno la scena clubbing ora ma la conosco molto bene. Alla Biennale abbiamo invitato Moritz von Oswald che è un compositore tedesco, pioniere della dub techno, ma ci saranno molte figure legate al genere, per esempio anche Carl Craig.
Secondo te la musica elettronica dovrebbe avere anche una responsabilità politica?
Credo che gli artisti abbiano la responsabilità di trasformare, attraverso la musica, le emozioni difficili come la tristezza o la rabbia, in bellezza. Fin da bambina per me la musica era catarsi: quando mi sentivo sopraffatta mi chiudevo in camera, suonavo la chitarra classica e mi sentivo meglio. Quindi penso che ci sia da una parte un dono, ma dall’altra un vero e proprio dovere. Durante un concerto una persona può mettersi in ascolto della sua parte più intima e profonda. E se siamo bravi ad ascoltare diventiamo empatici e possiamo davvero trovare nuovi modi di coesistere all’interno di una comunità. Questo per me è un atto politico.
Che cosa ti dà davvero soddisfazione oggi?
Offrire un’alternativa al capitalismo. Non solo grazie alla Biennale ma anche con il mio lavoro singolo e con la mia etichetta, vedendo che ce la si può fare, anche economicamente mantenendo questa libertà di spirito.
L’intervista a Caterina Barbieri è anche sul nuovo numero di Billboard Italia, The Electronic Issue, disponibile in store selezionati e ordinabile qui.